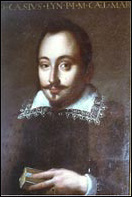  |
Federico Cesi nasce a Roma, nel palazzo di via della Maschera
d'Oro, il 26 febbraio 1585 da Federico, marchese di Monticelli (dal 1588
primo duca di Acquasparta, e dal 1613 principe di San Polo e di Sant'Angelo),
e da Olimpia Orsini di Todi.
Primogenito maschio di undici figli legittimi, viene battezzato il 13
marzo 1585 nella chiesa di San Simeone, adiacente al palazzo. Il duca,
padre di Federico, ha fama di essere un uomo di cattiva indole, grossolano
e ignorante, pessimo amministratore dell'ingente patrimonio della casata,
mentre la duchessa madre è una donna pia e raffinata, che esercita
molta influenza sull'educazione del figlio.
Pochissime sono le notizie sull'infanzia e l'adolescenza di Federico;
la sua formazione viene curata da due "lettori" privati, ai
quali si affiancano, in un secondo momento, Francesco Stelluti, per la
geografia, e Johannes van Heeck, per la filosofia.
Lo stretto legame che unisce Federico con i suoi due maestri e con Anastasio
de Filiis, parente dei Cesi, sancisce la nascita del sodalizio linceo
nel 1603.
Nel 1614 sposa la giovane Artemisia Colonna, figlia di Francesco principe
di Palestrina e di
Ersilia Sforza, che muore dopo appena due anni senza avere avuto figli.
Nello stesso anno, 1616, sposa in seconde nozze Isabella Salviati, figlia
di Lorenzo marchese di Giuliano e di Maddalena Strozzi. In onore degli
sposi Stelluti pubblica l'epitalamio "Il Pegaso".
Dall'unione nasce nel 1623 un primo figlio maschio, Federico, che muore
dopo tre giorni dalla nascita. Nel 1626 nasce un secondo maschio, morto
anch'egli appena nato. Delle due figlie femmine, una prende il velo e
l'altra sposa in prime nozze il marchese Ludovico Lante e, in seconde
nozze, Paolo Sforza marchese di Proceno.
Il Celivago, come viene chiamato Federico all'interno dei Lincei, muore
nel palazzo di Acquasparta, prematuramente e senza lasciare testamento,
il 1° agosto 1630 a 45 anni.
Federico Cesi, nobile umbro
Federico Cesi era un patrizio umbro che nel 1603, quando
aveva diciotto anni, fondò a Roma un sodalizio con tre amici, l'olandese
Giovanni Heckius (italianizzato in "Ecchio") e altri due umbri,
come lui, Francesco Stelluti e Anastasio de Filiis, denominando tale compagnia
Academia Lynceorum, 'Accademia dei Lincei', per l'eccezionale acutezza
di sguardo attribuita alla lince […].
Nella volontà di Federico Cesi, oggetto dello studio suo e dei
suoi compagni erano tutte le scienze della natura, indagate con libera
osservazione sperimentale, al di là da ogni vincolo di tradizione,
anche se con atteggiamento di rispetto nei confronti della precedente
tradizione aristotelico-tolemaica. Le novità erano grandi, a cominciare
dall'interesse per le scienze della natura, tenuto anche conto della folla
di accademie essenzialmente letterarie della società italiana fra
la fine del Quattrocento, il Cinquecento e il Seicento: basti pensare
all'Accademia della Crusca, della seconda metà del Cinquecento,
linguistico-letteraria, fino alla seicentesca Accademia dell'Arcadia,
poetico-letteraria, tanto per ricordarne le più illustri e ancor
oggi esistenti.
Federico Cesi estese la sua Academia Lynceorum a molti altri dotti italiani
e stranieri, fino al numero di una trentacinquina; il che dice la severità
di ammissione del Cesi, ma insieme anche la sua volontà di estendere
l'Accademia fuori dai confini di Roma […]: ecco il napoletano Della
Porta, ecco il tedesco Faber Schmidt, che fu a lungo Cancelliere dell'Accademia;
con estensione anche dei temi trattati, fino al Tesoro messicano, sulla
flora, sulla fauna e sulla farmacopea del Nuovo Mondo. L'Heckius presentava
i Lincei come "arcanorum sagacissimi indagatores scientiarum et paracaelsicae
dediti disciplinae" […].
Ignazio Baldelli

|
|
|

