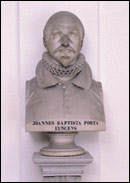 |
Giovambattista della Porta nasce a Vico Equense nel 1538
– sebbene la data esatta della nascita sia discussa - e muore a
Napoli nel 1615.
Filosofo, scienziato e autore di commedie, è noto soprattutto per
l'opera Magia naturalis, che inizia a scrivere a quindici anni,
e che lo impegnerà per tutta la vita. Non riceve una formazione
universitaria e i suoi insegnanti sono tutti precettori privati, per lo
più ignoti, a parte il filosofo e medico reale di Napoli, Antonio
Pisano, e il naturalista calabrese Domenico Pizzimenti.
Il padre, Leonardo di Antonio Della Porta, dal 1541 presta servizio alla
corte dell’Imperatore Carlo V, e il giovane Giambattista ha occasione
di viaggiare molto in Italia e in Europa. Ha così modo di frequentare
le biblioteche europee e di conoscere molti insigni studiosi, oltre a
poter acquistare libri rari e preziosi. In diverse occasioni citerà
le sue esperienze di viaggio, in particolare nell’opera Villae,
dove descrive molti dei luoghi visitati: la Calabria, le Puglie, la Lombardia,
Venezia, la Francia, la Spagna.
I suoi interessi spaziano dal tema della rifrazione della luce alla botanica,
dall'alchimia al magnetismo, alla fisiognomica, alla magia.
Tra le discipline da lui maggiormente coltivate vi sono l'astrologia,
l'ottica, la matematica, la meteorologia, la botanica.
Nel 1558 pubblica a Napoli la Magia naturalis sive de miraculis rerum
naturalium libri IV, opera che lo rende noto a livello europeo e
nella quale, tra scienza e magia, cerca di approfondire la conoscenza
dei fenomeni naturali e tenta di dimostrare che alla base di fenomeni
ritenuti misteriosi vi sono cause naturali: per questa ragione viene accusato
di stregoneria. A Napoli fonda l’Accademia dei Segreti, con l’intenzione
di riunire gli studiosi interessati soprattutto alla scoperta delle cause
dei fenomeni naturali.
Nel 1579 viene invitato dal Cardinale Luigi d'Este a Roma,
quindi a Venezia. Durante questi soggiorni lavora alla realizzazione di
dispositivi ottici, tra cui uno specchio parabolico.
E' sua l'idea di inserire un obiettivo nell'apertura dell'obscura
della macchina fotografica, contribuendo allo sviluppo della fotografia.
I suoi studi dell'occhio umano danno impulso alla conoscenza dell'oftalmologia.
Nella sua abitazione allestisce un personale museo di storia naturale,
aperto al pubblico, dove esibisce animali, minerali e piante rari, raccolti
e collezionati durante i suoi viaggi, contribuendo così alla maturazione
del concetto di museo pubblico.
Nonostante i suoi rapporti con i Gesuiti e i Teatini, che dimostrano la
sua adesione agli ideali della riforma cattolica, le sue pubblicazioni
sono più volte vietate dall'Inquisizione, che giunge a negargli
la possibilità di scrivere di scienza e di filosofia e perfino
di condurre ricerche scientifiche.
 |
Nel 1586 pubblica il più importante testo di fisiognomica
del periodo, il De Humana Physiognomonia. Anche in questo caso
va incontro al veto delle autorità ecclesiastiche. Il trattato
viene più volte ristampato: nel 1610 anno dell’ingresso
del Della Porta all’Accademia dei Lincei e nel 1637, a cura
di Francesco Stelluti.
Al 1589 risale la pubblicazione della seconda edizione
della Magia naturalis in venti libri, alla cui stesura il Della
Porta ha lavorato per oltre venti anni.
Contemporaneamente alle attività scientifiche, coltiva la passione
per il teatro e scrive molte opere, tra cui Olimpia, Penelope,
Fantesca. Nei primi anni novanta del Cinquecento, la censura
ecclesiastica si inasprisce e il Della Porta viene colpito dal divieto
di stampare qualunque opera che non abbia ricevuto il consenso del Sant’Uffizio,
in particolare la versione volgare della Fisionomia umana, che
pubblicherà qualche anno dopo con lo pseudonimo Giovanni de Rosa
a Napoli.
Nel 1604 Federico Cesi principe linceo fa visita all'anziano mago-scienziato
a Napoli per il quale nutre una profonda ammirazione.
Il Della Porta è stato tra i primi nuovi lincei iscritti all'Accademia,
dopo la crisi iniziale del sodalizio. La sua sottoscrizione ufficiale
ai Lincei, all'età di settantacinque anni, risale all'8 luglio
1610, mentre nel 1612 viene nominato Vice-Principe del Liceo di Napoli,
la prima e unica sede distaccata dell'Accademia.
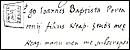 |
Per Cesi il Della Porta scrive un compendio della storia e genealogia della
sua famiglia, il cui argomento viene ripreso nella dedica al Cesi stesso
dell’opera De distillatione, pubblicata nel 1608, contenente
numerose scoperte chimiche. In questo periodo inizia la diatriba tra il
Della Porta e Galileo circa la paternità dell’invenzione del
cannocchiale. Sebbene in seguito egli decida di riconoscere a Galileo il
merito del perfezionamento dello strumento, nel 1610 l’Accademia dei
Lincei, per opera del Cesi, attribuisce a Della Porta l’invenzione.
Nel 1613 lo scienziato napoletano riceve dai Lincei una medaglia, consegnata
da Francesco Stelluti che giunge a Napoli per acquistare un edificio per
la sede partenopea dell’Accademia. In questa occasione il fabrianese
cerca anche di convincere Della Porta a lasciare in eredità ai Lincei
la sua preziosa biblioteca, ma quando il 4 febbraio 1615, dopo una breve
malattia, lo studioso muore a Napoli nella casa della figlia Cinzia, questa
viene nominata insieme alla sua famiglia erede di tutto il patrimonio, compresa
la biblioteca.

|
|
|

